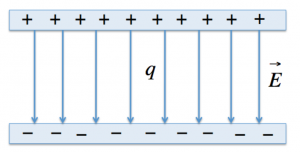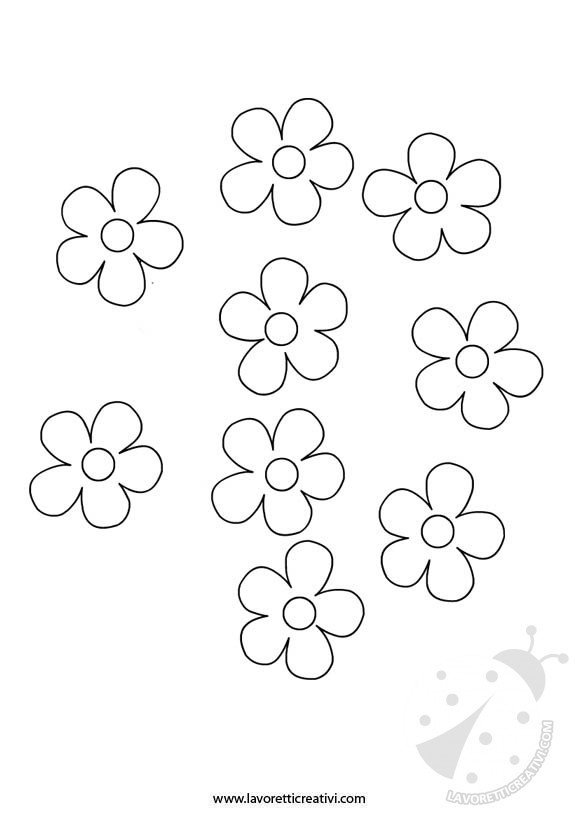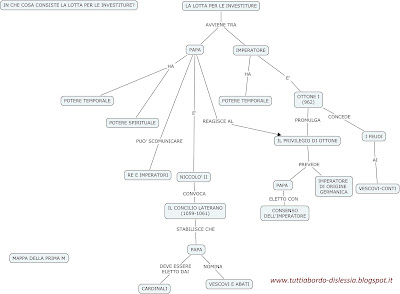È possibile trattare dell’Università dal punto di vista del lavoro? È possibile in altre parole discutere delle attuali condizioni di vita e lavoro dell’universitario – ricercatore e docente – occupandosene alla stregua di una forma di lavoro dipendente? No, perché all’accademico è strutturalmente richiesta un’adesione sostanziale alle norme e consuetudini che presiedono al funzionamento del corpo e dell’apparato di riproduzione culturale e sociale di cui è parte, e perché esercita – sempre meno, in verità – una funzione intellettuale non assimilabile ad uno status di lavoro subordinato. Sì, perché l’evolversi della normativa universitaria, e soprattutto della pratica quotidiana, sempre più sembra attribuire all’accademico un ruolo impiegatizio-burocratico a metà strada tra l’insegnante e il quadro/funzionario pubblico. Vale dunque la pena tornare ancora una volta a riflettere sulle trasformazioni che nell’ultimo ventennio hanno investito l’Università, favorendo processi di intensa burocratizzazione, frammentazione delle funzioni e dei ruoli, erosione delle attribuzioni intellettuali a vantaggio di logiche aziendaliste, retoriche meritocratico-valutative, sostituzione delle “competenze” al “sapere”, che si traducono in conformismo culturale e adesione ai modelli sociali dominanti. Pubblichiamo la prima parte della riflessione di Luca Baldissara.
Quello che – in qualità di ricercatore e docente – si svolge in Università è un lavoro? Può cioè essere descritto, analizzato e compreso con gli strumenti e le categorie che normalmente impieghiamo per restituire il profilo professionale e le specificità del rapporto di lavoro?
Sì e no. Sì, perché l’evolversi delle condizioni lavorative in Università sempre più avvicina e nelle forme assimila attualmente il lavoro di un accademico a quello di un funzionario pubblico. No, o almeno non del tutto, perché questo mestiere non solo mantiene condizioni di lavoro fluide, non rigidamente classificabili in termini di mansioni e orari, ma perché l’accademico non assolve esclusivamente ad incarichi di ricerca ed insegnamento, in qualche modo opera entro un apparato ideologico di riproduzione culturale e sociale – e dunque è chiamato ad aderire alle norme che ne regolano il funzionamento – e svolge una funzione intellettuale non immediatamente classificabile nei termini di una condizione subordinata di lavoro. Di qui, l’ambiguità e la difficoltà di una riflessione su cosa significhi lavorare ed operare nell’Università odierna, costantemente in bilico tra spinte alla burocratizzazione ed alla “impiegatizzazione” d’un canto, e, dall’altro, sollecitazioni a rinnovare e legittimare prassi riproduttive di un corpo specializzato e separato, con interessi generali e privilegi specifici, obiettivi politici e funzioni scientifiche, ruoli culturali e mansioni sociali. Cosicché, l’Università al tempo stesso è, o può essere, ambiguamente e contraddittoriamente, luogo di conservazione della tradizione e viceversa spazio di libertà critica, strumento di riproduzione della gerarchia e dell’ordine sociale o viceversa vettore di emancipazione ed elevazione, ambito di rassicurante conformismo politico-culturale o stimolatore di creativa innovazione.
E’ il contesto che circonda l’istituzione universitaria a fare la differenza. A portare ora l’uno ora l’altro dei suoi contraddittori profili a prevalere. E oggi – nel quadro di una profonda crisi del modello di Università, messa sotto crescente pressione da pratiche aziendaliste, ideologie meritocratico-valutative e retoriche dell’efficienza, nonché dalla sostituzione del “sapere” con la “competenza” – l’Università nel suo complesso appare piegata al conformismo culturale, all’accettazione ed alla riproduzione dei modelli sociali dominanti (o comunque alla subalternità ad essi), alla trasformazione delle sue funzioni attraverso un processo di intensa e incessante burocratizzazione, nonché di parcellizzazione e atomizzazione di funzioni e responsabilità.
Note di contesto. Dell’attuale sistema universitario
Non è dunque possibile discorrere e confrontarsi intorno a cosa significhi lavorare oggi all’Università prescindendo dalla considerazione di cosa sia divenuta nell’ultimo ventennio l’istituzione accademica. Perché l’attuale assetto universitario è il risultato di frenetici e radicali innesti legislativi ed organizzativi che si sono realizzati in avvio del XXI secolo.
E’ con il c.d. processo di Bologna che – pur confluendo su linee di tendenza che già andavano prefigurandosi nel decennio precedente – si inaugura la stagione della profonda riorganizzazione dell’Università che conduce all’attuale situazione. Nel giugno 1999, 29 ministri europei dell’educazione si riuniscono a Bologna per concordare un disegno di costruzione di uno “spazio europeo dell’istruzione superiore”, per la prima volta evocato nella Dichiarazione della Sorbona dell’anno precedente (nella quale si delineavano anche la strutturazione in due cicli del sistema universitario di formazione, primo e secondo livello, incentivando il ricorso ai “crediti”, e l’articolazione dei periodi di studio in “semestri” al fine di accrescere le possibilità degli studenti di accedere ovunque in Europa alle strutture universitarie). A Bologna si definiva quindi il c.d. “3+2” (laurea triennale + laurea specialistica biennale, oggi laurea magistrale), articolato in semestri e fondato sul sistema dei crediti formativi universitari (CFU) per facilitare l’armonizzazione ed il riconoscimento in ambito europeo dei titoli di studio. Si concordava inoltre sulla necessità di una sistematica valutazione della qualità delle istituzioni accademiche, certificata da agenzie nazionali indipendenti. Il nostro paese – attraverso l’operato dell’allora ministro Luigi Berlinguer – aderiva con entusiasmo al modello così delineato: già nell’a.a. 1999/2000 alcuni atenei avviavano la sperimentazione del sistema 3+2, l’anno successivo entrato a regime in tutte le Università del paese.
Nel 2010, nelle conferenze di Vienna e Budapest, si approdava al varo definitivo dello Spazio europeo della formazione superiore, a cui nel frattempo avevano aderito anche diversi paesi confinanti con l’UE, nel complesso 47 stati. E nel 2010 veniva approvata in Italia la cd. Legge Gelmini (legge 30 dicembre 2010 n. 240), dal nome dell’allora ministro in carica nel quarto governo Berlusconi, Mariastella Gelmini di Forza Italia, che avrebbe introdotto significative ed importanti novità nella costituzione formale e materiale dell’Università italiana. Si trattava di interventi che trovavano il loro presupposto politico in un documento del novembre 2008, le Linee guida del governo per l’Università, che sostanzialmente preannunciavano il forte ridimensionamento del sistema universitario italiano (effettivamente realizzatosi nel successivo decennio), legittimandolo con alcuni argomenti, in buona parte pregiudiziali e strumentali a quanto si intendeva fare.
A rendere urgente e necessario un intervento governativo di ridefinizione del sistema accademico erano, secondo le Linee guida, l’eccessivo costo dell’Università italiana (con una spesa per studente tra le più alte e tasse di iscrizione troppo basse), la scarsa “produttività” del sistema (un numero esorbitante di studenti fuori corso, un’età media dei laureati troppo alta, un eccesso di docenti), la dequalificazione del titolo di laurea, l’opacità delle pratiche di autogoverno dei professori. Con termini quali “gestione responsabile”, “sostenibilità economica”, “merito come criterio di scelta”, si prefigurava la razionalizzazione e riduzione degli insegnamenti e dei corsi di studio, l’allocazione delle risorse sulla base dell’attestazione di un’agenzia di valutazione della ricerca, una ridefinizione dei meccanismi di governance (strutture di governo e modelli organizzativi), l’attivazione di nuove e più limpide forme di selezione e reclutamento. Solenni dichiarazioni di principio e frusti stereotipi buoni per ogni stagione (relativi, ad esempio, allo strapotere dei “baroni” universitari) – insieme ad elementi reali di cronico malfunzionamento dell’accademia – trovavano un amalgama nel clima anti-intellettuale della nostra epoca, spianando la via in Parlamento e nell’opinione pubblica all’approvazione della legge. Che il mondo universitario, pur nell’eco di non poche voci discordanti, nella sua gran parte accoglieva, aderendovi in alcuni settori, e per lo più adeguandosi in base ad un principio di rassegnato e recalcitrante adattamento a quella che si riteneva la reale situazione dei concreti rapporti di forza.
La Legge Gelmini dava dunque forma concreta a questi orientamenti, attribuendo sostanzialmente al governo la delega – intorno ad una cinquantina erano infatti i necessari decreti delegati di attuazione – alla definizione degli interventi. Il criterio della sostenibilità economica del sistema – marcato del frequente ricorso alla formula “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” – comportava di fatto la centralizzazione delle decisioni e della definizione degli indirizzi, riservate in pratica al Miur di concerto al Mef. Tale accentramento decisionale – con buona pace dell’ossequio all’autonomia – aveva come riflesso un accentramento interno agli atenei stessi derivante dalla ridefinizione delle strutture di governo. La legge infatti disponeva il rafforzamento del Rettore (in carica ora per sei anni senza possibilità di ricandidarsi) attraverso l’attribuzione del potere di nomina sui membri esterni del Consiglio di Amministrazione (Cda); l’aumento dei poteri del Cda sul Senato Accademico (Sa, composto solo da professori) e la speculare diminuzione dei poteri del Sa, che da organo decisionale passava ad essere organo consultivo; il rafforzamento del direttore amministrativo, ora direttore generale; l’assenza di organi decisionali e/o di coordinamento tra dipartimenti e ateneo in grado di bilanciare la minore rappresentanza dei dipartimenti in Sa; l’individuazione di soglie minime di numerosità dei dipartimenti, con conseguente spinta alla loro aggregazione senza riguardo all’omogeneità ed alla coerenza scientifica.
In concomitanza con l’approvazione della Legge Gelmini, si realizzava inoltre un ulteriore intervento destinato a condizionare profondamente da allora in poi il funzionamento dell’Università italiana, l’attivazione dell’Anvur, l’Agenzia per la valutazione del sistema universitario, creata nel 2006, ma resa operativa dall’adozione nel 2010 del regolamento che ne stabiliva modi e forme del funzionamento e dalla nomina del comitato direttivo. Rispetto al momento in cui era stata pensata come ufficio di assicurazione della qualità, in linea con gli orientamenti emersi alla conferenza interministeriale di Berlino del 2003 ed alla successiva tenutasi a Bergen (ministri Letizia Moratti poi Fabio Mussi), l’Anvur gelminiana veniva ad assumere un nuovo profilo, in linea con gli orientamenti della legge allora in gestazione: l’agenzia avrebbe dovuto costituire lo strumento per realizzare “un sistema integrato di valutazione che vincoli il finanziamento ai risultati, incentivando l’efficacia e l’efficienza dei programmi di innovazione e di ricerca, la qualità della didattica, lo svolgimento dei corsi in lingua inglese, la capacità di intercettare finanziamenti privati ed europei, il tasso di occupazione dei laureati coerente con il titolo di studio conseguito”.
Di fatto, si dava vita ad un ente dotato di ampi poteri, che andavano ben oltre la valutazione del sistema, attribuendo all’Anvur una vera e propria funzione di controllo dell’Università, intervenendo nella ripartizione delle risorse tra atenei – anche ricorrendo all’uso strumentale dei fondi premiali da attribuire alle Università “virtuose” nel quadro di una costante contrazione del fondo di finanziamento ordinario erogato dallo Stato – ed esprimendo pareri vincolanti in ambiti che dovrebbero essere di competenza esclusiva del Ministro. Altro che agenzia indipendente di valutazione della qualità! L’Anvur veniva a configurarsi come un “ministero ombra” dell’Università, con funzioni prescrittive e standardizzanti nei confronti degli atenei (e dunque del personale universitario), in tal modo limitati e fortemente condizionati nelle loro scelte. L’Anvur esercitava cioè una vera e propria funzione politica di governo del sistema universitario per via tecnocratico-amministrativa, via via erodendo attribuzioni e competenze del ministero, sempre più svuotato di poteri effettivi a vantaggio di un apparato sottratto al controllo politico d’indirizzo.
Con buona pace dei tanto declamati principi di autonomia e collaborazione, la Legge Gelmini e l’entrata in funzione dell’Anvur hanno finito con il produrre una doppia verticalizzazione: nazionale, con il governo, il ministero e l’Anvur che provvedono a definire obiettivi e indirizzi strategici tanto per il sistema nel suo complesso quanto per le sue componenti (atenei e personale), stabilendo parametri e regole entro le quali le Università devono operare, nonché fissando minuziosi criteri di funzionamento di corsi di laurea e di dottorato, vincolando i finanziamenti a parametri rigidi che non tengono in alcun conto le specificità delle diverse realtà universitarie né le loro differenze di contesto; locale, con il rafforzamento all’interno dei singoli atenei del potere dei gruppi accademici più forti, e in essi dei soli professori ordinari (gli unici che possono ricoprire la quasi totalità degli incarichi di governo delle strutture), e del Rettore, la cui legittimazione attraverso una sola verifica elettorale – l’impossibilità del rinnovo di fatto annulla il problema del consenso e della coesione della comunità universitaria, più facilmente riconducendo il governo ai nudi rapporti di forza tra componenti – sommata alla contestuale debolezza degli organi di controllo configura la forma di governo d’ateneo alla stregua di una monarchia costituzionale.
Assetti di potere, gerarchie e conformismo
La gestione del personale è coerente con questo impianto centralistico, verticistico, aziendalistico. La Legge Gelmini come è noto eliminava la figura del ricercatore a tempo indeterminato (il ruolo in organico di maggiore novità introdotto dalla legge di riforma 382/1980, che doveva valorizzare il potenziale di ricerca dell’Università e stabilizzare le figure del precariato accademico seguite alla liberalizzazione degli accessi di fine anni Sessanta). La sostituiva con quella del ricercatore a tempo determinato, le cui funzioni sono simili ma regolate da un rapporto di natura precaria e di diritto privato, instaurato su base contrattuale, e attraverso una selezione che ha luogo nella forma del concorso pubblico. Peraltro, a moltiplicare e frantumare le forme del rapporto di lavoro, la legge prevede due tipologie di contratti per i ricercatori a tempo determinato: tipo a), di durata triennale e prorogabile per soli due anni; tipo b), ancora un contratto triennale, non rinnovabile, riservato a candidati che in precedenza hanno usufruito di contratti, assegni di ricerca, borse post-dottorato o posizioni analoghe all’estero. Questa seconda tipologia contrattuale gode inoltre di un meccanismo automatico di accesso al ruolo di professore associato qualora il ricercatore abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a tale ruolo; in tal caso, all’Università compete la valutazione del titolare del contratto, senza alcun giudizio comparativo, e, in caso di esito positivo, di inquadrarlo appunto nel ruolo dei professori associati.
Il reclutamento delle fasce di docenza è invece distinto in due momenti successivi: nel primo, il candidato è sottoposto al giudizio di una commissione nazionale di cinque professori ordinari costituita per ogni singolo settore scientifico disciplinare, cui spetta il compito di verificare i requisiti per svolgere le funzioni di professore di prima (professore ordinario) o di seconda fascia (professore associato), senza alcun limite numerico di coloro che possono conseguire l’abilitazione. Nel secondo momento, qualsiasi candidato che disponga dell’abilitazione può partecipare presso le singole Università ad un concorso pubblico bandito in relazione ai posti da coprire per i diversi settori concorsuali e scientifico-disciplinari. Nel quadro di una narrazione pubblica che propone questo meccanismo come un contrappeso al localismo delle scelte e delle procedure di reclutamento, il suo effettivo e concreto funzionamento tende a confermare e promuovere percorsi di selezione interni ai singoli dipartimenti ed agli atenei, favorendo i settori di maggior peso e forza accademica. E produce un modello di reclutamento che di fatto spinge gli atenei a scegliere la via quasi esclusiva della messa a bando di posti di ricercatore t.d., meno gravosi sul bilancio.
Il risultato si può riassumere in questi termini: da una parte, si espande la precarietà e la subalternità accademica, giacché il personale in attesa di stabilizzazione del rapporto di lavoro è potenzialmente – e inevitabilmente – sottoposto alla pressione del sistema in forma di crescente carico di lavoro e di omologazione dell’attività scientifica e del comportamento; dall’altra, si riduce la mobilità di carriera, creando una piramide con una sempre più ampia base di professori associati (con la promozione dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio e l’assunzione di nuovi ricercatori a t.d. che di fatto, in un tempo variabile tra i tre e gli otto anni, diverranno in gran parte associati) e un vertice di professori ordinari sempre più ristretto, conseguentemente generando la concentrazione del potere e delle responsabilità di governo nelle mani dei professori di prima fascia e la frustrazione, l’incertezza, la demotivazione, la competitività a cascata in chi si trova in condizione subordinata, dall’associato con maggiore anzianità al ricercatore t.d. appena entrato in servizio (magari in età non più giovane, già con un lungo percorso di precarietà extra-accademica alle spalle). In tal modo ottenendo probabilmente il tanto ambìto risparmio sulle spese di personale, ma certo minando la coesione della comunità accademica, favorendo la disillusione e il disimpegno, incoraggiando l’acquiescenza e il conformismo.
Nell’illusione di definire un sistema che “oggettivamente” misuri e garantisca la qualità dei candidati e di coloro che verranno quindi reclutati, è stata inoltre stabilita la norma per cui l’abilitazione (per entrambe le fasce di docenza) sia da attribuire esclusivamente ai candidati che, dopo che ne sia stata quantificata e standardizzata la produzione scientifica, raggiungano determinati valori soglia. In altri termini, a seconda dei vari settori concorsuali, sono utilizzati indicatori minimi di attività scientifica. Si fissa in questo modo un requisito preliminare del tutto automatico – e non di reale valutazione scientifica nel merito – che stabilisce se un candidato possa o meno sottoporsi al giudizio della relativa commissione di abilitazione e a quest’ultima di procedere alla valutazione.
Con il risultato di incoraggiare una tendenza conformistica dell’attività scientifica, in primis della pubblicazione dei risultati della ricerca. Perché i requisiti automatici e i parametri formali che vengono individuati come essenziali per il conseguimento dell’abilitazione divengono i criteri guida di definizione delle carriere e dei curricula scientifici degli aspiranti alla carriera universitaria. E il conformismo non può che frustrare e penalizzare la creatività, motore della ricerca e dell’innovazione scientifica. Se per venire valutati positivamente e nutrire legittime speranze di carriera uno studioso deve ad esempio pubblicare su riviste che l’Anvur abbia stabilito siano di riferimento nel proprio ristretto settore scientifico disciplinare – dunque entro parametri normalizzati, uniformati e tipizzati – come si potrà ritenere che quello stesso ricercatore venga sollecitato a tentare via diverse da quelle standardizzate, ponendosi ad esempio all’incrocio tra metodi e discipline differenti, nessuna delle quali assai presumibilmente vorrà prenderselo in carico?
Il sistema universitario che si è venuto definendo nell’ultimo ventennio, con un’accelerazione evidente dal 2010 in avanti, è dunque connotato da una spiccata concentrazione del potere accademico e da un rafforzamento della struttura piramidale e gerarchica dell’organizzazione universitaria. A questo tratto di fondo si somma la definizione di standard astratti e conformistici di valutazione delle strutture stesse e del personale, che comporta una sostanziale subalternità tanto ai gruppi accademici egemoni quanto agli indirizzi dominanti della ricerca. Fattori negativi che vengono resi più dannosamente incisivi dal permanere e consolidarsi delle forme di instabilità ed incertezza professionale (i ricercatori a tempo determinato, che vedono dilatati i già lunghi tempi di stabilizzazione nei ranghi universitari e prolungata la condizione di subalternità scientifica e culturale, dovendo conformarsi a metodi di valutazione standardizzata), dalla riduzione massiccia del personale (che in molti settori si è contratta sino al 30/40 per cento rispetto ai primi anni duemila), dal progressivo decremento del finanziamento pubblico degli atenei, dalla sempre più intensa burocratizzazione che le norme sui vincoli di spesa e quelle sulla classificazione e certificazione della qualità impongono.
Tra gli altri effetti, tutto ciò ha comportato un’intensa accentuazione della già marcata frammentazione del sistema. Nel senso sia della forte diversificazione interna all’organizzazione accademica, sia della frantumazione dell’esperienza individuale, a seconda che ci si riferisca ad atenei del sud o del centro-nord, ad atenei di grandi o medie dimensioni, di antica o recente istituzione, a settori universitari dell’area delle scienze umane o di quelle naturali, mediche o fisico-matematiche, ad ambiti professionalizzanti o di formazione generale, alla condizione di professore ordinario o associato, ovvero di ricercatore a tempo determinato, e si potrebbe continuare. Appare insomma impossibile svolgere qualsiasi ragionamento che, oltre la ricostruzione di un quadro generale degli ordinamenti e degli assetti, quale pure si è qui tentato, consenta di trattare del sistema universitario nel suo complesso. Un tale sistema, infatti, ormai esiste solo nella forma di apparato organizzativo, di amministrazione della struttura accademica di educazione, e non più come istituzione in grado di presiedere ad un coerente percorso di formazione superiore, di governare ed indirizzare una collettività di individui associati nell’attività di studio e scambio di esperienze intellettuali, nell’acquisizione di sapere e consapevolezza, nell’esercizio della conoscenza critica di sé, del mondo, del presente. Il che rende anche difficile, al limite oggi dell’inimmaginabile, sviluppare un discorso politico e civile sulle prospettive e su una potenzialmente diversa idea di Università.
(continua nella parte seconda)
 Send to Kindle
Send to Kindle